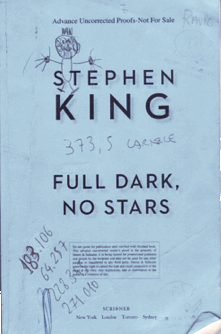Che differenza c’è tra la scrittura di un proprio romanzo e la traduzione di un romanzo altrui in un’altra lingua?
Quando scrivi un romanzo, prima scrivi e poi leggi quello che hai scritto. Ovvero: sei prima scrittore e poi lettore. Quando traduci, è l’esatto contrario: sei prima lettore e poi scrittore. L’esperienza iniziale del testo è uguale a quella di qualunque altro lettore. Solo che, dopo aver terminato di leggere, devi porti il problema di distruggere e ricostruire da capo quel che hai appena letto.
Detta in altri termini: nel tradurre un romanzo altrui ti trovi di fronte a un testo già definito, «chiuso», con il cemento già inserito nelle fessure. E’ come avere il software ma non il codice-sorgente. Ti manca il «backstage» della storia che stai leggendo: il processo che dall’ispirazione iniziale ha portato al risultato che hai sotto gli occhi, le stesure provvisorie, le motivazioni di certe scelte, le discussioni coi lettori di prova etc. Devi ritrovare tutto questo con un metodo «indiziario», cioè: partendo da alcune caratteristiche del testo, cerchi di immaginarti quali possano essere state le scelte, perché questa parola e non un suo sinonimo più comune?, perché la scelta di far compiere al personaggio la tale azione quando al suo posto chiunque ne avrebbe fatta un’altra?, e la spiegazione che l’autore fornisce è una semplice «toppa» (perché ormai la storia era andata in una certa direzione e cambiare tutto sarebbe stato troppo dispendioso) oppure era prevista fin dall’inizio? Un traduttore ha bisogno di compiere questa «indagine», per poter interrogare il testo nel modo migliore e così trovare le risposte adeguate.
Invece, quando scrivi un romanzo tuo, queste cose le vivi in presa diretta. Il testo è aperto, i mattoni sono solo appoggiati, puoi ridisporli svariate volte prima di trovare l’assetto giusto.
Come ci si organizza per tradurre un gigante della letteratura occidentale come Stephen King?
Leggo King da tantissimi anni, da quand’ero ragazzo, e ho recensito diversi suoi libri, ho scritto articoli su di lui, ma non lo avevo mai tradotto. Prima di cominciare, mi sono ri-immerso nel suo mondo, ho consultato svariate fonti, letto molte cose su di lui, riletto alcuni libri di importanza capitale nella sua produzione. Dopodiché, mi sono messo di buona lena. Non c’è altra scelta che farsi il mazzo.
I libri di S. King conoscono una lunga tradizione di traduzioni italiane, essendo stato traslato fin dall’inizio della sua carriera, e da più di un traduttore. Tu in che modo ne hai tenuto conto, soprattutto in riferimento al conosciutissimo Tullio Dobner?
Come ogni suo Fedele Lettore sa bene, i libri di King contengono sempre riferimenti ad altri suoi libri, è un mondo di continui riferimenti incrociati. Quando ne trovavo uno, cercavo il testo nella traduzione di Dobner. A volte ce l’avevo in casa, altre invece no, perché molti libri del Re li ho letti in inglese. In un modo o nell’altro, anche grazie alla Rete, trovavo quel particolare passaggio, vedevo come l’aveva tradotto Dobner e cercavo di tradurlo in modo che fosse coerente. Ad esempio, ho visto che non dovevo tradurre il toponimo informale «the Barrens», perché in italiano si è conservata la parola inglese, solo togliendo la «s» finale. Oppure, nel terzo racconto della raccolta un personaggio, inesplicabilmente, si trova in bocca una frase che ricorre nel ciclo della Torre Nera. Una frase semplice, ma che si poteva tradurre con diverse scelte sintattiche. L’ho ritrovata nella versione di Dobner, e ho usato quella.
Quanto pesano le aspettative dei lettori del Re in un lavoro come questo?
Pesano tantissimo, ma uno deve scordarsele. Sai già che le tue scelte non potranno piacere a tutti. Sai già che molti aficionados delle traduzioni dobneriane rigetteranno il tuo lavoro a prescindere, o andranno a cercare peli nelle uova, e qualcuno cercherà di seminare zizzania, di mettermi contro Dobner, e mettere lui contro di me. Anzi, qualcuno ci sta già provando. Te ne fotti, e cerchi di fare un buon lavoro.
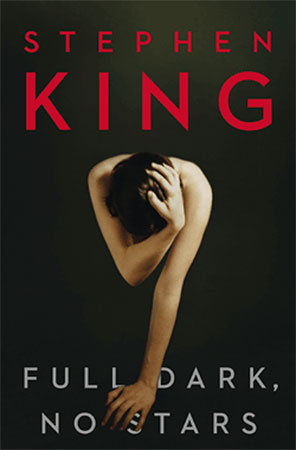 Tu sei un grande estimatore di Stephen King, di cui conosci presumibilmente l’opera omnia. Ogni nuova opera del Re costituisce una realtà a sé, pur essendo spesso collegata tramite riferimenti interni ad altri lavori precedenti. FULL DARK, NO STARS sembra essere una raccolta atipica rispetto ad altri lavori, essendo completamente dedicata alle donne e ai loro mostri. In che modo la tua conoscenza dei lavori precedenti di King può influire sulla traduzione di quest’ultimo libro?
Tu sei un grande estimatore di Stephen King, di cui conosci presumibilmente l’opera omnia. Ogni nuova opera del Re costituisce una realtà a sé, pur essendo spesso collegata tramite riferimenti interni ad altri lavori precedenti. FULL DARK, NO STARS sembra essere una raccolta atipica rispetto ad altri lavori, essendo completamente dedicata alle donne e ai loro mostri. In che modo la tua conoscenza dei lavori precedenti di King può influire sulla traduzione di quest’ultimo libro?
Mentre traducevo, mi è sembrato importante tornare con la mente alle atmosfere di alcuni romanzi «al femminile» di King, come Dolores Claiborne, Il gioco di Gerald, La storia di Lisey… Due novelle della raccolta («Maxicamionista» e «Un bel matrimonio») sono in quella linea evolutiva. King sta diventando sempre più empatico nell’esplorare la psiche dei personaggi femminili, è uno dei pochi scrittori maschi che riesce a calarsi a fondo nei meandri di quello che per molti colleghi è un «mistero doloroso», come quelli del Rosario, nella parte che va dall’arresto di Gesù alla crocifissione. Per molti scrittori, compresi noi Wu Ming, gli sforzi per rendere plausibile un personaggio femminile, per farlo vivere (e non solo vegetare) sulle pagine, compone una vera e propria via crucis. Invece per King la scrittura «al femminile» è un mistero gaudioso, un po’ come l’Annunciazione dell’angelo a Maria. King trova sempre le soluzioni più felici, e ogni volta che sceglie una protagonista annuncia una crescita, un nuovo cambio di passo.
Sappiamo che Stephen King è anche uno sperimentatore. Soprattutto con le opere dell’ultimo decennio (ma non solo) ci ha spinti ad accogliere un linguaggio in evoluzione. Qual è il confine tra la novità linguistica che può essere rinvenuta in questo volume e lo stile già sviluppato in passato e ormai ben delineato? E quali sono le particolarità della lingua inglese usata da King?
La sperimentazione kinghiana è subdola, è un esempio di quel «sovvertimento sottile» della lingua, quella terza opzione tra sperimentalismo e lingua «di servizio» di cui parlavo nel libro New Italian Epic. Di primo acchito potrebbe sembrare una lingua piana, finalizzata unicamente a portare avanti l’azione. Invece è attraversata in lungo e in largo da piccoli «effetti» che la tengono in movimento, viva, pulsante. L’effetto «inebriante» che ha la prosa di King su chi legge, quel non potersi fermare, quella voglia di girare le pagine, di stare a lungo dentro quel mondo, non è soltanto una questione di ritmo, di passo narrativo, anche se King è un maestro del ritmo. Non è l’azione a portare avanti il tutto. Come hanno fatto notare in diversi, ad esempio lo scrittore Beppe Sebaste (altro «kingologo» di razza), le parti dei libri di King che leggiamo più volentieri sono quelle di «bonaccia», quelle dove apparentemente non succede nulla. Perché? Perché quelle sono le parti che io chiamo di «costruzione di mondo». Con una sapienza stilistica e descrittiva che i critici non sanno quasi mai riconoscere (peggio per loro!), pennellata dopo pennellata, gioco di parole dopo gioco di parole, in un gioco di inflessioni locali, riferimenti ultra-specifici e veri e propri «tormentoni» (battute che vengono ripetute più e più volte), King costruisce intorno a noi una comunità, e ci cala dentro di essa. E’ il suo lavoro sulla lingua a permetterci di entrare. Basti fare due esempi: la seconda novella di Cuori in Atlantide, con quel gergo incredibile legato a un arcano gioco di carte, e – soprattutto – La storia di Lisey, dove si intrecciano linguaggi «privati», si ammucchiano neologismi… Quanto al «tormentone», pensiamo a come parla Wireman in Duma Key, con tutti quegli «amigo», «muchacho», e le sue frasi ricorrenti etc. Chiaramente, per un traduttore è una faticaccia cercare di rendere tutto questo in un’altra lingua. C’è sempre il rischio di «sbracare». Il fatto che i libri di King tradotti sinora siano – come suol dirsi in inglese – «unputdownable» (cioè: non li puoi mettere giù) anche in italiano, testimonia che prima di me è stato fatto un buon lavoro, ed è il minimo che possa dirsi. Spero di aver fatto un buon lavoro anch’io.
C’è stato un punto del testo o un momento particolare della traduzione che ti ha messo a dura prova?
I giochi di parole sono infernali. Alcuni sono riuscito a renderli, con vere e proprie acrobazie di spremitura di meningi. Altri mi hanno costretto a rinunciare a certe risonanze, a vantaggio di altre. Nella quarta novella, «Un bel matrimonio», c’è un uso della parola «Links» che era impossibile riprodurre in italiano. A volte mi sono trovato in un’impasse e ne sono uscito con l’aiuto degli editor della casa editrice, in primis Elisabetta Ricotti.
Una delle principali caratteristiche di questo scrittore del Maine è costituita dal fatto di usare un linguaggio tipico della sua zona. In che modo hai risolto il problema del dialetto usato da King e, più in generale, dei numerosi riferimenti interni al testo e forse pienamente comprensibili solo da un americano?
In questo libro non c’è molto dialetto, rispetto ad altri della produzione kinghiana. Invece abbondano – cosa che è tipica del Re – i riferimenti ad aspetti molto specifici della cultura popolare e di massa americana, tutte cose che da noi non hanno corrispettivi: determinati alimenti e prodotti alimentari, programmi tv che i lettori italiani non conoscono, linee di arredamento… In quei casi, poiché non puoi cavartela con una nota a pie’ di pagina (la nota a pie’ di pagina è l’ammissione di uno «scacco», di una sconfitta, inoltre la Sperling & Kupfer non le usa), devi lavorare sulle parole che stanno intorno, in modo da far capire – pur senza fare il cosiddetto «spiegone» – di cosa si tratta. Un esempio: nella Postfazione della raccolta, King racconta di essere uscito da un autogrill con un Three Musketeers. Io ho dovuto tradurre: «una barretta Three Musketeers». Insomma, ho dovuto aggiungere una parola. Sembra una cosina ininfluente, ma 1) ho dovuto fare una scelta: aggiungere anche «al cioccolato» oppure no? Meglio di no, la parola «barretta» fa già capire di cosa si tratta. 2) Se questo genere di «esplicitazioni» ricorre nel testo troppo spesso, tutto diventa pedante. E allora ogni volta devi capire quanto lasciare al lettore e quanto invece servirgli su un vassoio.
Senza anticipare contenuti particolari, di cosa parla FULL DARK, NO STARS?
Principalmente di vendetta. La vendetta è il filo conduttore di tutte e quattro le storie. E poi di violenza sulle donne, fisica e psicologica. Anche nel racconto dove in apparenza non c’è violenza sulle donne (niente stupri, niente torture, niente omicidi, niente dolorosi raggiri), all’origine di tutta la vicenda c’è comunque una contesa tra maschi su una donna, un istinto predatorio frustrato.
Circolano voci che anche King avrebbe un ghost writer, soprattutto negli ultimi romanzi. Tu ne sai qualcosa?
Se davvero circolano, non sono che tristi minchiate, offensive nei confronti di un autore che dedica tanto tempo, metodo e sforzi quotidiani allo scrivere come prassi concreta, «mestiere» serio e rigoroso.
Infine, vorrei chiederti quale è stato, secondo te, l’influsso della letteratura di King sull’arte di scrivere romanzi in Occidente (o, se lo ritieni, in tutto il mondo).
Prima parlo in generale: l’influenza di King sulla popular culture mondiale non è misurabile, ma si può presumere che sia stata enorme, dato che non c’è arte né medium in cui non la si senta di riffa o di raffa: cinema, musica rock, fumetti, videogame, giochi da tavolo, giochi di carte, videoclip, T-shirt etc. Per quanto riguarda l’influenza strettamente letteraria, non credo di essere in grado di rispondere, dovrei avere una conoscenza minimamente decente della letteratura di tante parti del mondo. Chi lo sa, magari in Perù, o in Sudafrica, o in Corea del Sud ci sono scrittori che devono a King la decisione di fare quel mestiere. Anzi, è probabile. King fa venire voglia di scrivere, di raccontare. Quel che è certo è che in Italia molti scrittori – e non solo di horror e thriller – devono a King tanto del loro stile e dell’immaginario che esplorano. Non credo che avremmo Niccolò Ammaniti o Simona Vinci, senza l’influenza del Re (soprattutto del Re di Stagioni diverse, mi viene da dire).
Fabrizio Valenza